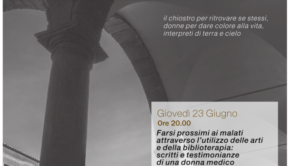Libri e altre inquietudini
Fra le melensaggini e i luoghi comuni più frequentati dagli sprovveduti e dai non addetti ai lavori ve n’è una tutta particolare ed è quella riguardante la lettura.
Questa gente, e si noti è gente dabbene, della quale per riservatezza non si faranno i nomi, ma sono veramente i più numerosi, è solita dire che in Italia è andata perduta la confidenza con l’opera scritta, che i giovani non leggono più e che, insomma, nessuno fa lo sforzo, ai giorni nostri, di decifrare quei caratteri, che per comodità chiameremo tipografici, preoccupandosi di attribuire loro un senso che vada oltre un suono e che generino un moto dell’animo, in quell’animo giovanile pur incline al gesto eclatante, che sappia andare oltre l’ilike (mi piace) o, nei casi più clamorosi, la pubblica condivisione della citazione.
E questo stato delle cose è ritenuto unanimemente attributo di demerito dinanzi al quale qualunque uomo prudente e nel pieno delle proprie facoltà mentali è tenuto a esprimere biasimo, censura, più spesso rammarico, come nel noto manuale di conversazione di Andrea Ballarini che, per il Foglio, cura una rubrica per fare buona figura senza necessariamente sapere quel che si dice. In questo che, sciascianamente, vuole essere un contributo alla confusione, ci proponiamo di mettere in evidenza come l’apparente disinteresse sociale al libro, e a ciò che in esso è conservato, non solo è antico ma è anche fondamento e fortuna della nostra Civiltà.
Scriveva nel 1967 Giorgio Manganelli: «Qualche tempo fa durante una discussione qualcuno citò finché c’è al mondo un bambino che muore di fame fare letteratura è immorale. Qualcun altro chiosò allora lo è sempre stato. Supponiamo che la saggezza dei governanti, la sistemica collera dei governati, la pia collaborazione dei venti e delle piogge consentano, tra qualche generazione di annunciare: «da oggi, lunedì, nessun bambino morirà più di fame». Non sorgerà allora qualche onesto e lucido raziocinatore a rammentarci i suicidi, le morti precoci, i delitti passionali, gli alcolizzati?»
Vi è un interessante fatto storico librario, in verità una mera questione interna a una disciplina che studia la teoria e i metodi della ricerca, descrizione e classificazione dei libri allo scopo di produrre repertori atti ad agevolare il lavoro intellettuale e che si chiama «Bibliografia». Ebbene, dal Concilio di Trento in poi le edizioni della Commedia di Dante Alighieri scesero a picco. Se fra il 1472 e il 1500 si registrano ben 15 edizioni dell’opera del poeta fiorentino, in tutto il 1600 ne sono riscontrabili solo 3.
E questo fatto almeno una spiegazione potrebbe avercela.
 Quando il conte di Tournay, Charles de Brosses, sul finire degli anni ’30 del 1700 giunse a Roma rimase assai deluso in quanto non la trovò neoclassica. E lui che masticava i sillogismi della filosofia scolastica, per definire la Città Eterna, lui che sarebbe stato compilatore di Enciclopedie, mise in fila 3 vocali che sono: A-O-O. Le quali, nell’impianto di tale corrente di pensiero, stanno a indicare una contraddizione totale, un sistema che non si regge in piedi, e fu così che ebbe conio una parola molto cara a noi siciliani: Barocco.
Quando il conte di Tournay, Charles de Brosses, sul finire degli anni ’30 del 1700 giunse a Roma rimase assai deluso in quanto non la trovò neoclassica. E lui che masticava i sillogismi della filosofia scolastica, per definire la Città Eterna, lui che sarebbe stato compilatore di Enciclopedie, mise in fila 3 vocali che sono: A-O-O. Le quali, nell’impianto di tale corrente di pensiero, stanno a indicare una contraddizione totale, un sistema che non si regge in piedi, e fu così che ebbe conio una parola molto cara a noi siciliani: Barocco.
Il barocco, invenzione oculatissima del Concilio di Trento e delle due menti teoriche, Carlo Borromeo e Gabriele Paleotti, non incoraggiò mai la lettura nel nostro bel paese, vuoi con l’Index Librorum Prohibitorum, vuoi con una strategia volta alla sintesi di esperienze artistiche popolari in cui avrebbero interagito le arti della musica (e si pensi al violino), le immagini, la pompa dei vestiti e tutto ciò che avrebbe poi manifestato la sua grandezza nella corte di Luigi XIV, ovvero il teatro, e che in Italia si ritrova per la prima volta a Mantova, all’inzio del ‘600: l’Opera, plurale di opus latino, sintesi di elementi artistici dai quali viene però esclusa la letteratura. Luigi XIV, che saccheggiando Philippe Daverio, definiremo una invenzione italiana, lo è per davvero, grazie a Giulio Mazzarino, l’uomo nuovo nato nella corte dei papi di Roma. Manca la letteratura, tanto cara all’uomo del Rinascimento fiorentino, che era intellettuale oltre che fabbro e che mai avrebbe accettato la scomparsa della distinzione fra arti maggiori e minori.
E se c’è una cattiveria che Lutero ha commesso è stata quella di obbligare ogni famiglia tedesca a saper leggere e scrivere per approcciarsi ai Testi Sacri, in modo non molto dissimile da quello che avviene nelle scuole coraniche. E si capisce che questo è stato un crimine sociale. Da noi, continua Daverio, si optò per un’altra strada: per favore non leggete. E, date le ultime statistiche sull’analfabetismo funzionale, possiamo affermare, con margini di dubbio sicuramente trascurabili, che gli italiani obbediscono tutt’ora, come galleggiando sull’onda lunga dell’ignoranza.
Dalle nostre parti, a detta del critico e mercante d’arte, si fonda l’Italia moderna, “democristiana” ante litteram, dove tutto ha un ordine, dove si vive in pace e ognuno sta al proprio posto. Dove il vescovo fa il vescovo, il conte fa il conte, il preposto fa il preposto e dove la perpetua ha quarant’anni, in modo da non essere fertile ed evitare scandali. Una società quella italiana e curiale che è uscita praticamente indenne dalle guerre europee (pensiamo a cosa è stata la guerra dei 30 anni per la Germania), che ha vissuto in una relativa serenità fino alle tragedie del ‘900, e che oggi si ritrova questo immenso patrimonio artistico del quale non sa cosa farsene, non solo perché ha costruito di più, ma anche e soprattutto perché ha distrutto di meno. E tutto questo grazie a quel patto sociale, continua Daverio, istituito col Concilio di Trento.
Un bene sì, certamente, ma è una pace dettata dall’assopimento intellettuale e dalla circolazione controllata e furtiva dei libri, che sono idee. Quando gli intellettuali, che poi sono i poeti, gli scrittori e i melodrammatici, sono tornati in campo ecco che è stato generato quel moto tutto sommato silenzioso del Risorgimento, invenzione della letteratura (si pensi alla Nazione del Risorgimento di Alberto Banti).
Checché se ne dica, la nostra non è una Civiltà del Libro se con questo termine non intendiamo solamente la produzione del libro tipografico, lo splendido oggetto in sé, che grazie alla raffinatezza dei nostri maestri cartai, grazie ai fonditori di eleganti caratteri tipografici (si pensi all’italico erroneamente attribuito a Manuzio, o ai caratteri arabi di Alessandro Paganino) è divenuto il primo prodotto di design italiano apprezzato nel mondo. Riprova ne sono le contraffazioni francesi e olandesi.
I libri venivano stampati da italiani, certamente, ma con falsi luoghi di stampa, grazie ad editori nostrani operanti all’estero “religionis causa” (e ci riferiamo ai lavori di Ugo Rozzo e Marco Santoro). Il libro rimane comunque un orpello, e l’intellettuale è sempre diabolico perché crea scompiglio e scoperchia i tetti delle case, quando non spia da sotto il pavimento, come il diavolo, che essendo sotto terra, è sempre a due passi da noi.
La situazione non sembra diversa al tempo di Giacomo Leopardi, il poeta recentemente disturbato dalla cinematografia. Leggiamo infatti nei Pensieri, III:
«La sapienza economica di questo secolo si può misurare dal corso che hanno le edizioni che chiamano compatte, dove è poco il consumo della carta e infinito quello della vista. Sebbene in difesa del risparmio della carta dei libri si può allegare che l’usanza del secolo è che si stampi molto e che nulla si legga […] cose quanto belle a vederle, tanto più dannose agli occhi nella lettura; ma ben più ragionevoli in un tempo nel quale i libri si stampano per vedere e non per leggere».
Si sbagliava Gesualdo Bufalino quando affermò in un’intervista ancora oggi consultabile su YouTube che la mafia si combattesse con i libri. Subito dopo il «Crucifige!», mai stoltezza più fatale è stata pronunciata. Ma allevia il nostro patire concedere al Gran Comisano il beneficio del dubbio per il quale potremmo continuare a supporre, oltre ogni ragionevole riserva, che, come spesso è accaduto, gli procurasse intimo diletto il vederci schiantare contro punte di scogli. Infatti molte sono le vessazioni attribuibili a uomini del libro.
Ci sia consentito partire dai casi più noti senza attardarci, oltre il veloce e pure dovuto rinvio al caso dell’abate Giuseppe Vella, il falsario maltese divenuto nel secolo scorso ancora più celebre grazie a Leonardo Sciascia e al suo Consiglio d’Egitto. A lui oggi è stato affiancato da Silvano Nigro lo stesso Andrea Camilleri contraffattore di parole. Tornando a Sciascia sarebbe interessante rievocare, preoccupandosi di avvicinare a sé un’acquasantiera, il diabolico e quindi doppio protagonista di Todo Modo, e parliamo di don Gaetano e del suo eremo di Zafer (ulteriore minzogna saracina), la cui cripta – nella quale i Democristiani dell’epoca, Lui compreso, pregavano – sembra ricordare l’inferno di Dante, esoterico al modo dell’Islam, e nel quale si custodiva il noto quadro di Niccolò Buttafuoco, presente anche nella pellicola con Marcello Mastroianni e Gian Maria Volontè, raffigurante il Diavolo con gli occhiali nell’atto di tentare il Santo che con occhi affaticati consulta i Vangeli. Don Gaetano, manco a dirlo, era un prete cattivo che aveva letto tutti i libri.
Sebbene su Diavoli e Occhiali non sia più il caso di trattenersi da quando Nigro ha pubblicato Il portinaio del diavolo: occhiali e altre inquietudini, Bompiani 2014, chiede menzione la vicenda di Enea Silvio Piccolomini, il quale nel 1454 scrive una epistola al cardinal Juan de Carvajal, rimasta la più antica fonte sulla Bibbia di Gutenberg. Nella missiva il Piccolomini esprime meraviglia per la nitidezza e per la leggibilità dei caratteri, giacché sine labore et absque berillo legeret. La Bibbia che si legge senza binocolo, senza occhiali e che, a posteriori diciamo noi oggi, avrebbe potuto liberare il Santo dalla fatica della lettura e dalla conseguente tentazione del demonio. Il lettore nello scritto del Piccolomini avverte però un’ansia nuova, un moto da furore d’aver libri, una preoccupazione d’avere la prima edizione già impegnata, ed ecco i germi di una malattia rara nella sua forma più acuta, ma che miete vittime senza remissione: la bibliofilia. Ecco la rivincita del Maligno.

Ritroveremo più avanti Enea Silvio Piccolomini sul soglio di Pietro con il nome di Pio II, il papa protettore della stampa in Italia, in preda a un’irresistibile voglia di proclamare. I suoi Commentarii, continua don Gaetano, sembrano voler dire: «Guardatemi, qui sul soglio di Pietro; sono il vecchio Enea Silvio, quello della Storia dei due amanti; ce l’ho fatta, ve l’ho fatta…» Davvero un eroe stendhaliano avant la lettre.
Ah Stendhal, sempre adorabile lui… colui il quale partecipò più che attivamente al saccheggio di Mosca azzoppando la collana volterriana di uno sconosciuto moscovita.
Poi c’è Marcello dell’Utri, collezionista folle e utopico che ha messo insieme almeno 100.000 volumi, adesso nella sua biblioteca di via Senato a Milano, pubblica dal 1996. Per essere chiari sono custoditi incunaboli ed edizioni stampate tra il ‘500 e l’800 delle botteghe di Aldo Manuzio, dei Giunta, degli Elzevier; raccolte di prime edizioni del ‘900 italiano. Ora, le male lingue, dicono che sia andato in Libano pieno di contanti per sottrarsi al tribunale della giustizia del popolo italiano. Noi, che invece apparteniamo a un genere differente dell’umanità, noi, sappiamo che Marcello in Oriente fosse impegnato in faccende assai più rilevanti e ricercate che la fuga o la cura del sé, quelle cose degli uomini fatti di carne, di ossa e di sangue e che danno il pane a Travaglio.
Dell’Utri in Libano cercava libri.